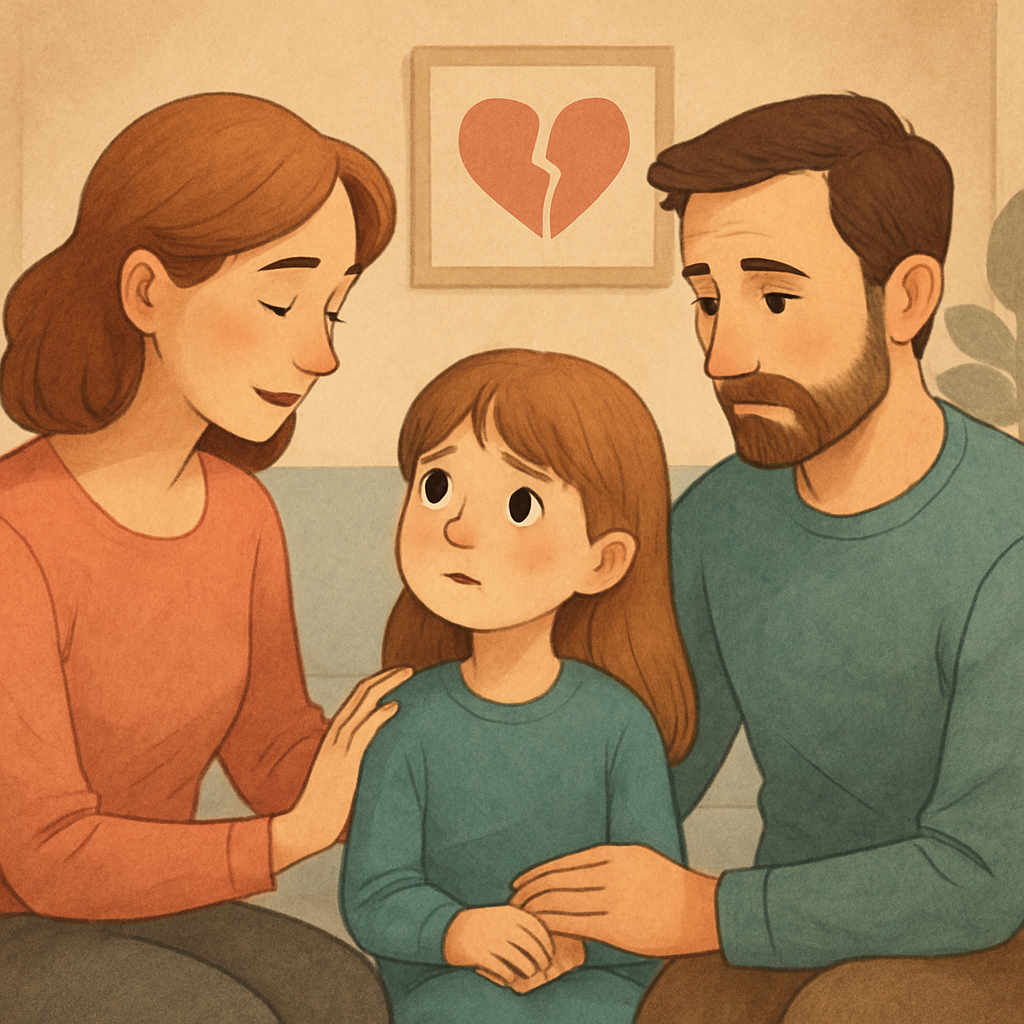Affidamento condiviso: cosa prevede la legge italiana e come funziona nella pratica
Affidamento condiviso: cosa prevede la legge italiana e come funziona nella pratica
La separazione di una coppia comporta decisioni importanti che riguardano non solo il rapporto tra i due adulti, ma soprattutto il futuro dei figli. In Italia, il principio dell'affidamento condiviso si pone come soluzione privilegiata per tutelare il diritto dei minori a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. In questo articolo approfondiremo cos'è l'affidamento condiviso, cosa prevede la legge italiana, quali sono i diritti dei genitori e dei figli, e come viene attuato nella pratica.
Panoramica della legge 54/2006 sull'affidamento condiviso
L'affidamento condiviso è stato introdotto ufficialmente con la Legge n. 54 del 8 febbraio 2006, entrata in vigore il 16 marzo 2006. Questa normativa ha rappresentato una vera e propria rivoluzione nel diritto di famiglia italiano, ponendo il concetto di "bigenitorialità" al centro delle scelte relative ai figli dopo una separazione o un divorzio.
Prima di questa legge, era prassi che i figli venissero affidati prevalentemente a uno solo dei genitori, con l'altro che manteneva semplicemente un diritto di visita. La legge 54/2006 ha invece stabilito che, salvo casi particolari, è nell'interesse del minore mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori, che devono condividere le responsabilità relative alla crescita e all'educazione del figlio.
In particolare, l'articolo 337-ter del Codice Civile stabilisce che l'affidamento condiviso è la regola generale, mentre l'affidamento esclusivo è l'eccezione e viene disposto solo quando l'affidamento a uno dei genitori sia considerato più rispondente all'interesse del minore.
Principio di bigenitorialità e sue implicazioni
Il principio di bigenitorialità è il cuore dell'affidamento condiviso. Questo principio si basa sul diritto fondamentale del bambino a mantenere rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori, anche in caso di separazione o divorzio.
Le principali implicazioni del principio di bigenitorialità sono:
- Parità di responsabilità: entrambi i genitori mantengono il diritto e il dovere di prendere decisioni importanti relative all'educazione, alla salute e alla crescita del figlio.
- Presenza equilibrata: si cerca di garantire che il bambino trascorra tempi significativi con entrambi i genitori.
- Collaborazione: è incentivata una collaborazione effettiva tra i genitori, anche se la loro relazione affettiva si è interrotta.
In pratica, il giudice invita i genitori a concordare un piano genitoriale che definisca tempi, modalità di frequentazione e modalità decisionali condivise.
Gestione del tempo e delle responsabilità genitoriali
Uno degli aspetti più delicati dell'affidamento condiviso riguarda la gestione del tempo che il figlio passerà con ciascun genitore e la ripartizione delle responsabilità.
Il giudice, o gli stessi genitori in caso di accordo, stabiliscono:
- Residenza abituale del minore, ovvero il luogo in cui il bambino risiederà principalmente.
- Tempi di permanenza: è definito un calendario che prevede giorni, fine settimana, vacanze estive e festività da trascorrere con ciascun genitore.
- Ripartizione delle spese: in genere è prevista una contribuzione economica proporzionata alle disponibilità di ciascun genitore.
Importante sottolineare che, pur mantenendo la residenza prevalente presso un genitore, il figlio deve avere un rapporto continuativo anche con l'altro genitore.
Nella pratica, i modelli più diffusi di gestione del tempo sono:
- Permanenza prevalente presso un genitore e visite regolari con l'altro.
- Ripartizione equilibrata (esempio: 50/50 tra i genitori).

Differenze tra affidamento condiviso e affidamento esclusivo
È importante distinguere tra affidamento condiviso e affidamento esclusivo:
- Affidamento condiviso: entrambi i genitori partecipano attivamente alla crescita del figlio, condividendo decisioni importanti.
- Affidamento esclusivo: solo uno dei genitori ha il potere decisionale sulle questioni principali, mentre l'altro ha semplicemente un diritto di visita.
Il giudice può disporre l'affidamento esclusivo solo quando uno dei genitori è ritenuto inadeguato o pericoloso per il benessere del figlio.
Errori da evitare nella gestione dell'affidamento condiviso
Gestire correttamente l'affidamento condiviso è essenziale per il benessere dei figli. Alcuni errori comuni da evitare:
- Parlare male dell'altro genitore davanti ai figli.
- Usare i figli come strumento di pressione o ricatto.
- Non rispettare gli accordi stabiliti.
- Ignorare i bisogni emotivi dei figli.
I bambini devono sentirsi liberi di amare entrambi i genitori senza sentirsi in colpa o costretti a schierarsi.
Ruolo del giudice e possibilità di mediazione familiare
Il giudice ha un ruolo fondamentale nell'attuazione dell'affidamento condiviso. Se i genitori raggiungono un accordo, il giudice si limita a ratificarlo, sempre che rispetti l'interesse superiore del minore. In caso contrario, interviene stabilendo le modalità di affidamento e regolamentando i rapporti.
Quando le tensioni tra i genitori rendono difficile un accordo, il giudice può disporre l'intervento di un servizio di mediazione familiare. La mediazione familiare è uno strumento che aiuta i genitori a:
- Comunicare in modo più efficace.
- Costruire accordi condivisi e duraturi.
- Ridurre i conflitti dannosi per i figli.
La mediazione è volontaria, ma in alcuni casi il giudice può invitare fortemente le parti a intraprenderla.
Cosa succede se uno dei genitori non rispetta gli accordi
Se uno dei genitori non rispetta gli accordi di affidamento condiviso, l'altro genitore può rivolgersi nuovamente al giudice. Le conseguenze possono includere:
- Modifica delle condizioni di affidamento.
- Provvedimenti di coercizione (multe, restrizioni).
- Eventuale revisione dell'affidamento a favore dell'altro genitore.
Il mancato rispetto degli accordi può essere considerato un comportamento lesivo nei confronti del diritto del minore alla bigenitorialità.
Ruolo dei servizi sociali e degli assistenti sociali
In alcune situazioni delicate, il giudice può disporre l'intervento dei servizi sociali per:
- Monitorare le condizioni di vita del minore.
- Supportare la famiglia nel superare conflitti.
- Fornire relazioni al giudice utili alla valutazione dell'affidamento.
Gli assistenti sociali agiscono sempre nell'interesse superiore del minore, favorendo soluzioni che garantiscano il suo benessere psicofisico.
Esempi pratici di accordi di affidamento condiviso
Un tipico esempio di accordo di affidamento condiviso prevede:
- Residenza abituale presso la madre.
- Permanenza presso il padre un fine settimana su due e due pomeriggi a settimana.
- Divisione equa delle vacanze natalizie, estive e pasquali.
- Partecipazione congiunta alle decisioni su scuola, salute e attività extrascolastiche.
Altri modelli prevedono la residenza alternata, con il bambino che trascorre una settimana con un genitore e la settimana successiva con l'altro.
Ad esempio, io personalmente trascorro con i miei figli una settimana, da domenica sera, fino alla domenica sera successiva, facendomi carico di tutte le loro attività (scuola, sport e altro), e la settimana successiva, invece la passano con la madre. Così via tutte le settimane.
A mio parere, questa situazione, paritetica, è la migliore se entrambi i genitori riescono a gestirla, e migliore anche per i figli.
Statistiche sull'affidamento condiviso in Italia
Statistiche sull'affidamento condiviso in Italia
Secondo i dati ISTAT degli ultimi anni:
-
L'affidamento condiviso viene disposto in circa l'85% dei casi di separazione con figli minori.
-
L'affidamento esclusivo è in netta diminuzione.
-
La maggioranza dei bambini continua a risiedere prevalentemente con la madre, ma il coinvolgimento paterno è in crescita.
Questi dati mostrano un trend positivo verso una maggiore responsabilità condivisa nella crescita dei figli. Tuttavia, è importante sottolineare che, nella pratica, "affidamento condiviso" non sempre significa una presenza eguale di entrambi i genitori nella vita quotidiana dei figli.
In molti casi, infatti, la residenza abituale viene stabilita presso la madre, con il padre che esercita il diritto di visita secondo un calendario stabilito. Questo comporta che i figli trascorrono comunque una quantità di tempo significativamente maggiore con la madre rispetto al padre.
Secondo recenti analisi, in circa il 70% dei casi di affidamento condiviso la madre è il genitore con cui i figli trascorrono la maggior parte del tempo. Questa situazione, sebbene prevista dalla legge per motivi pratici e di stabilità, rischia talvolta di ridurre l'effettivo ruolo educativo e affettivo del padre.
Per questo motivo, è fondamentale che i papà si impegnino attivamente per mantenere un ruolo costante e significativo nella vita dei figli. Non basta accontentarsi dei tempi minimi previsti dagli accordi: è importante cercare occasioni di presenza concreta, partecipare alla vita quotidiana, interessarsi alla scuola, allo sport, agli amici, alle passioni dei propri figli.
Essere presenti non significa solo rispettare i giorni di visita, ma costruire un rapporto autentico e profondo. I figli hanno bisogno di entrambi i genitori, non solo formalmente ma realmente. Ogni sforzo fatto in questo senso contribuisce a creare adulti più sereni, sicuri e capaci di costruire relazioni sane.
Invitiamo quindi tutti i papà a non considerare l'affidamento condiviso come una mera formula legale, ma come una missione attiva di amore, cura e presenza continua nella vita dei propri figli.
Le difficoltà economiche affrontate dai papà dopo la separazione
Un altro aspetto spesso sottovalutato riguarda le difficoltà economiche che molti papà si trovano ad affrontare dopo la separazione. Nonostante l'affidamento condiviso sancisca una parità di responsabilità genitoriale, nella pratica le spese per il mantenimento dei figli sono quasi sempre a carico in misura maggiore del padre.
Il genitore non collocatario – generalmente il padre – è spesso tenuto al pagamento di un assegno di mantenimento destinato ai figli. Questo, unito ai costi della propria nuova abitazione, delle spese vive per i figli (vestiti, scuola, attività sportive) e delle spese legali, comporta un carico finanziario non indifferente.
In molti casi, i padri si trovano a dover affrontare una drastica riduzione del loro tenore di vita. Alcuni, per poter far fronte agli impegni economici, sono costretti ad accettare lavori aggiuntivi o a rinunciare a spese personali importanti. Questa situazione può generare stress, frustrazione e, nei casi più gravi, può incidere negativamente anche sulla qualità del rapporto con i figli.
Eppure, nonostante queste difficoltà, è essenziale che i papà non rinuncino alla loro presenza attiva nella vita dei figli. La vicinanza emotiva e la partecipazione costante valgono molto di più delle risorse economiche. I figli hanno bisogno di sentirsi amati, supportati e compresi, indipendentemente dalle possibilità materiali.
Pertanto, è importante sensibilizzare anche le istituzioni sulla necessità di sostenere i padri separati, promuovendo politiche che favoriscano un equilibrio più equo tra responsabilità economiche e tempi di cura. Investire nella presenza paterna significa investire nel benessere e nel futuro dei bambini.
Conclusioni
L'affidamento condiviso è una grande opportunità per garantire ai figli la presenza attiva di entrambi i genitori, anche dopo la fine della relazione di coppia. È una scelta che richiede impegno, comunicazione e priorità assoluta all'interesse del minore. Con una buona pianificazione, l'aiuto di professionisti e tanta buona volontà, è possibile trasformare un momento difficile in un nuovo equilibrio familiare più sereno e rispettoso dei bisogni dei figli.